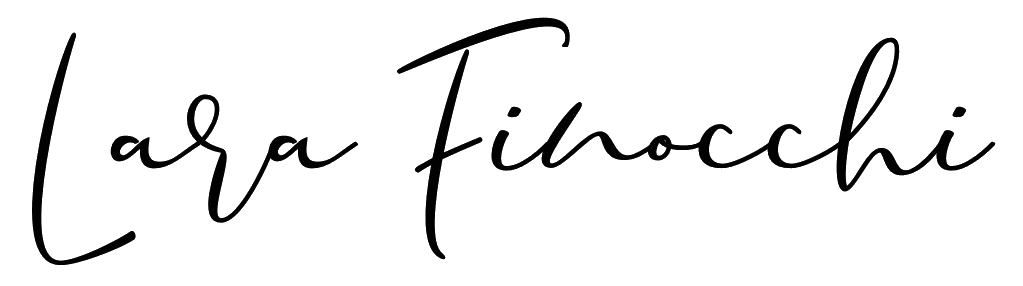2011, Padova, aula universitaria, corso di Psicologia Generale.
Durante la mia prima lezione da universitaria, mi è stato insegnato che la psicologia è una scienza.
In questo ambito, la ricerca viene svolta soddisfacendo tutti i criteri scientifici: ipotesi iniziale, variabili dipendenti e indipendenti, campionamento, test validati, etc.
È un approccio evidence-based.
Però, più studiavo e più questa versione della storia non mi convinceva.
A volte erano gli stessi professori a dire che il metodo aveva delle falle e, approfondendo la questione, ho iniziato a essere sempre più critica.
I test che mi somministravano durante gli esperimenti di psicologia (sì, gli studenti si prestano come soggetti per il bene della ricerca) mi sembravano antiquati e non al passo con i tempi. Alcuni erano palesemente risalenti agli anni novanta, con una visione della società e dei ruoli di genere non in linea con i tempi moderni.
Questo si riscontrava anche nei risultati dei test, quando venivi considerato/a troppo femminile o maschile sulla base di gusti personali.
Se il test fosse uno strumento di indagine che lascia il tempo che trova, queste criticità potrebbero essere ignorate.
Purtroppo però, vengono utilizzati durante le ricerche scientifiche e, dai risultati ottenuti, si inferiscono molti concetti: cosa rientra nelle categorie dei disturbi mentali e cosa no, quando si può definire una persona bisognosa di terapia e cura, quali sono i criteri diagnostici, quali medicine somministrare.
Va da sé che, se lo strumento di indagine non è validato correttamente o presenta delle forti criticità, questo influirà a cascata su tutta la narrazione e sulla metodologia che condizionerà la vita dei pazienti.
Ma passiamo al concetto di diagnosi.
Come si diagnostica un disturbo mentale?
I vari criteri sono contenuti ed elencati nel DSM, il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali.
In questo libro, che è definito ateorico perché non abbraccia solo una teoria di riferimento, ma viene aggiornato da un pool di professionisti, è possibile trovare l’elenco dei sintomi di ogni disturbo mentale, dal Disturbo d’ansia generalizzata alla schizofrenia.
Facciamo un esempio con il Disturbo depressivo maggiore.
Nel DSM sono indicate queste caratteristiche:
“Per la diagnosi di depressione maggiore, ≥ 5 dei seguenti sintomi devono essere stati presenti quasi ogni giorno durante lo stesso periodo di 2 settimane, ed uno di essi deve essere un umore depresso o una perdita di interesse o di piacere:
- Umore depresso per la maggior parte del giorno
- Marcata diminuzione di interesse o piacere per tutte o quasi tutte le attività per la maggior parte del giorno
- Significativi (> 5%) aumento o perdita di peso oppure diminuzione o aumento dell’appetito
- Insonnia (spesso insonnia di mantenimento [centrale]) o ipersonnia
- Agitazione o rallentamento psicomotorio osservati da altri (non auto-riferiti)
- Astenia o perdita di energia
- Sentimenti di autosvalutazione o di colpa eccessivi o inappropriati
- Diminuita capacità di pensare o concentrarsi o indecisione
- Pensieri ricorrenti di morte o di suicidio, un tentativo di suicidio, o un piano specifico per effettuarlo.”
Ora mi chiedo: per chi presenta 4 sintomi invece di 5, quindi non rientra nei casi di depressione maggiore, la vita com’è? Sta bene ed è felice? Perché secondo la psicologia non ha un disturbo.
Inoltre, queste categorie preconfezionate tendono a ridimensionare il vissuto del paziente utilizzando un linguaggio che non è pensato su misura per lui, ma è stato creato secondo dei criteri statistici.
Penso che ridurre la sofferenza di una persona a una singola etichetta sia sbagliato e controproducente.
Capisco che ci sia il bisogno di un vocabolario comune tra professionisti che si occupano dello stesso paziente, ma non possiamo ledere una persona già fragile per una nostra mancanza lessicale.
Ho notato con la pratica che i clienti, durante il primo incontro, mi riportano le loro diagnosi e si identificano con esse.
Quando sono già stati da un altro professionista, cioè la maggior parte delle volte, non mi raccontano per prima cosa il loro dolore, ma elencano sintomi e prescrizioni farmacologiche utilizzando un linguaggio così tecnico da appartenere a un esperto in materia.
D’altronde, a loro sono state fornite quelle parole per descrivere lo stato d’animo che le tortura da anni e quindi le utilizzano.
Le etichette sono ottime per ridimensionare ciò che risulta spropositato, capisco perché piacciano così tanto e abbiano una certa presa, ma rischiano anche di annientare la soggettività di una vita intera.
Sono un’arma a doppio taglio.
E non sto colpevolizzando i pazienti che le utilizzano, sto sottolineando le mancanze di un sistema che dovrebbe mettere il benessere e la salute delle persone al primo posto, non la comodità.
È da tempo che non sento la necessità di ridimensionare il dolore per aumentare la mia percezione di controllo, che la considero una pratica nociva e che sono una forte sostenitrice del cambiamento e della potenzialità dell’incertezza.
Per questo mi sono allontanata dalla Psicologia clinica e ho preferito le Discipline Analogiche.